Nella recente ordinanza 26850/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di giudicato implicito su questioni processuali.
Ormai la strada essere sembra tracciata, pur non mancando contrasti: salvo eccezioni (ovvero quando la violazione incida su interessi a rilevanza costituzionale oppure quando la norma preveda espressamente la rilevabilità in ogni fase e grado), sulle questioni processuali rigettate (espressamente o implicitamente), o anche non esaminate (perchè assorbite dalla pronuncia di rigetto nel merito), non oggetto di impugnazione incidentale, si forma il giudicato, con la conseguenza che il giudice d’appello non può esaminarle, nemmeno se riproposte ex art. 346 c.p.c.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, pur avendo rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione nel merito per mancanza di prova, non aveva preso in considerazione la questione della tardività di detta domanda sollevata dagli attori.
In appello, gli attori vincitori in primo grado si erano limitati a sollevare in via di mera eccezione la questione della tardività della domanda riconvenzionale e la Corte distrettuale in accoglimento dell’eccezione aveva dichiarato l’inammissibilità.
Gli appellanti soccombenti ricorrono in Cassazione per censurare la sentenza di secondo grado laddove dichiara l’inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale di usucapione. In particolare, i ricorrenti sostengono che l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dagli attori-appellati in secondo grado non avrebbe dovuto essere formulata in via di semplice eccezione, ma – al contrario – avrebbe dovuto essere introdotta nella forma e come motivo di appello incidentale ex art. 343 comma 2 c.p.c. avverso la sentenza non definitiva.
Detto motivo di ricorso viene giudicato fondato.
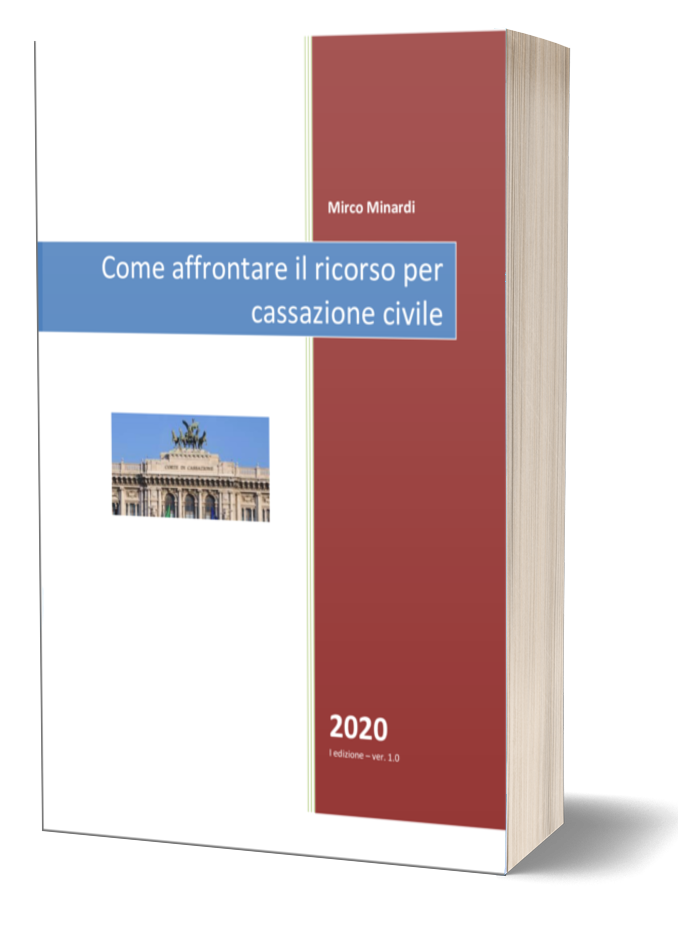
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio – ammissibile per essere stato prospettato nella sostanza un error in procedendo pur sotto la forma dell’error in iudicando – si evince che i controricorrenti avevano sollevato in primo grado l’eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale solo nelle memorie di replica alla comparsa conclusionale.
Inoltre, è pacifico che nella sentenza non definitiva di primo grado la questione della tardività della domanda riconvenzionale dei convenuti non risulta esaminata, avendo il Tribunale rigettato tale domanda per carenza di prova, senza dedicare alcun cenno alla questione della relativa tempestività.
Dal tenore di tale sentenza emerge, quindi, che l’eccezione circa la tardività della domanda riconvenzionale dei predetti convenuti Arcaro non ha formato oggetto di alcuna pronuncia di accertamento positivo, sia pure indiretta, ma è stata semplicemente trascurata dal tribunale.
Va dunque escluso che la sentenza di primo grado contenga alcuna statuizione di ammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti.
Tanto chiarito circa gli elementi processuali di rilievo nella specie in esame, la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere consiste nello stabilire se il giudice di appello debba e possa rilevare di ufficio la tardività di una domanda riconvenzionale che il giudice di primo grado abbia rigettato nel merito, senza, tuttavia, pronunciarsi sulla tempestività della medesima nonché sull’eccezione di tardività pure sollevata dalle controparti in primo grado, ma non introdotta dalle stesse in appello se non in via di mera eccezione.
La Corte ricorda che le soluzioni prospettate dalla giurisprudenza di legittimità alla problematica non sono univoche.
In senso contrario alla possibilità che la tardività della domanda riconvenzionale del convenuto, non rilevata in primo grado, possa, in difetto di specifica impugnazione sul punto da parte dell’attore, essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello sembra muovere l’argomentazione che si legge nella sentenza delle Sezioni Unite n. 11799 del 2017, là dove si afferma che il mancato esame di una eccezione pregiudiziale di rito astrattamente idonea a precludere l’esame di una domanda che, di fatto, sia stata esaminata dal giudice e rigettata nel merito onera la parte che l’aveva proposta, ancorché vittoriosa nel merito, di proporre appello incidentale, restando quindi preclusa, in mancanza di impugnazione, la possibilità per la parte di riproporre l’eccezione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.
E’ affermato testualmente in sentenza che:
«Può accadere che il giudice, nel pronunciare nel merito, rigettando la domanda, ometta di decidere su un’eccezione di rito proposta dal convenuto, nel senso che se ne disinteressi completamente. In tal caso il giudice non solo ha violato l’art. 276 cod. proc. civ., ma il suo disinteresse, a differenza di quello su un’eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell’eccezione ma senza alcuna possibilità di considerarla come effettiva, potendo, come s’è detto, il giudice solo avere scelto la soluzione più liquida. In questo caso, poiché l’eccezione di rito doveva esaminarsi prima del merito e ne condizionava l’esame, il silenzio del giudice si risolve però – ancorché la sua opinione sull’eccezione di rito non sia stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzione più liquida – in un error in procedendo, cioè nell’inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell’eccezione di rito. La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige allora una reazione con l’appello incidentale e non la riproposizione dell’eccezione di rito, perché è necessario che essa venga espressa con un’attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di rito» (in tal senso v. anche, Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n.6762 del /2021; Cass. n. 18369 del 2021).
Per la rilevabilità officiosa della inammissibilità della “domanda riconvenzionale” tardivamente proposta, non rilevata in primo grado e non dedotta con motivo di gravame, si è poi espressa, tra le altre, Cass. n. 7941 del 2020 e Cass. n. 24606 del 2006 che ritiene non preclusa la rilevabilità ex officio da parte del Giudice di appello della decadenza in cui la parte è incorsa in primo grado nella attività di “deduzione probatoria”, per inosservanza del termine perentorio assegnato dal Giudice, trattandosi di decadenza “sottratta alla disponibilità delle parti”; infine, nella pronuncia di cui Cass. n. 9297 del 2007, “qualora la questione di proponibilità non sia stata decisa in primo grado e non sia stata rilevata in appello nemmeno dal giudice, essa, ove non implichi un nuovo accertamento od apprezzamento di fatto, può essere prospettata in cassazione”.
L’argomento fondante della tesi è il seguente: nel caso in cui il vizio di nullità acceda come mero “presupposto logico” all’ingresso dell’esame e della decisione di una questione di merito (domanda od eccezione che sia), la statuizione della sentenza che decide sulla questione di merito, senza occuparsi del predetto vizio processuale (non eccepito né rilevato ex officio), non comporta – in difetto di specifica impugnazione volta a far valere il vizio presupposto – la cristallizzazione della invalidità/decadenza attraverso il “giudicato implicito interno”; con la conseguenza che non è dato ravvisare limiti alla denunciabilità/rilevabilità officiosa del vizio “in ogni stato e grado” del processo e quindi anche, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (salvo soltanto il giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. eventualmente formatosi sulla questione di merito dipendente).
Gli arresti delle sezioni unite della Corte – sentenze n. 24883 del 09/10/2008, n. 26019 del 30/10/2008 e n. 27531 del 20/11/2008, in particolare – hanno significativamente ridimensionato – secondo una interpretazione conforme degli artt. 24 e 111 Cost. – la portata fino ad allora assoluta della rilevabilità “in ogni stato e grado” del difetto di giurisdizione prevista dall’art. 37 c.p.c., offrendo un ulteriore apporto alla tesi del giudicato implicito sulle questioni processuali pregiudiziali, ed evidenziando come la norma sulla rilevabilità officiosa debba essere scrutinata non come mero controllo formale sulla esatta osservanza delle regole, ma sempre e solo in funzione dello scopo principale – prefigurato nella Carta costituzionale – di garantire la certezza della tutela giurisdizionale dei diritti in tempi ragionevoli (“la novità della previsione costituzionale [art. 111 Cost.] risiede proprio nel considerare ingiusto un sistema processuale che consenta, in alcuni casi, la protrazione del processo per un tempo irragionevole, o, comunque, non sia idoneo ad impedire tale protrazione normativamente, e cioè con una previsione valevole per tutti i casi”: Cass., Sez. Un., n. 26019/2008 cit.).
La questione è stata sottoposta nuovamente all’esame della Suprema Corte anche di recente, che nel condividere quest’ultima soluzione, l’ha sintetizzata nel seguente principio di diritto:
“il potere di rilievo “anche ex officio” dei vizi relativi alla attività processuale, attribuito dalla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività, deve essere esercitato dal giudice di merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione “in ogni stato e grado” ed escluse le ipotesi di “vizi relativi a questioni fondanti (che rendono l’attività svolta del tutto difforme dal modello legale del processo), al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestato, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio (o su eventuale sollecitazione della parte interessata all’esercizio di tale potere officioso), ove la relativa questione non abbia costituito specifico motivo di impugnazione, ovvero sia stata ritualmente riproposta, atteso che, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio (e nonostante la eventuale eccezione della parte interessata), la relazione di implicazione necessaria tra la soluzione – ancorchè implicita – adottata in ordine alla validità/ammissibilità della domanda/eccezione di merito (questione processuale pregiudiziale) e l’esame e la pronuncia espressa sulla domanda/eccezione (questione di merito dipendente), determina la intangibilità della decisione implicita sulla questione processuale ove non specificamente investita con i mezzi impugnatori, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., non trovando ostacolo nel carattere implicito della decisione la formazione del giudicato processuale interno.”
Nel condividere siffatta impostazione, il Collegio ritiene che, quindi, in questo caso il Tribunale di Isernia ha violato l’art. 276 c.p.c., trattando direttamente – e solamente – il merito della causa, senza affrontare dapprima la questione preliminare in rito riguardante la tardività della stessa domanda riconvenzionale, pure eccepita dalla controparte.
Tal disinteresse, a differenza di quello su un’eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell’eccezione ma può anche essere indice del fatto che il giudice ha solo scelto la soluzione “più liquida” per risolvere la controversia o, si tratta di una questione del tutto autonoma rispetto a quella, esaminata, relativa alla fondatezza della domanda medesima, sicché non può ragionarsi, in questo caso, in termini di assorbimento, che consente alla parte totalmente vittoriosa di riproporre la questione senza necessità di prospettare uno specifico motivo di impugnazione.
In questo caso, poiché l’eccezione di rito doveva essere esaminata prima del merito e ne condizionava l’esame, il silenzio del giudice si è risolto però (ancorché la sua opinione sull’eccezione di rito non sia stata manifestata e possa, in ipotesi, essere espressione di scelta della soluzione “più liquida”) in un error in procedendo, cioè nell’inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell’eccezione di rito; la violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esigeva allora una reazione con l’appello incidentale e non la riproposizione dell’eccezione di rito, perché è necessario che essa venga espressa con un’attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di rito.
Circa il modo in cui il giudice d’appello doveva esser investito, esso doveva consistere nella denuncia dell’esistenza del vizio della sentenza per l’eccezione di rito di cui trattasi (in termini Cass. n. 1791 del 2009; Cass. n. 10073 del 2003; Cass. n. 603 del 2003; Cass. n. 3927 del 2002; Cass. n. 14670 del 2001; Cass. n. 5482 del 1997).
In ogni caso, quindi, nella presente fattispecie la devoluzione al giudice d’appello dell’eccezione andava necessariamente introdotta da appello incidentale: tutte le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del primo giudice debbono essere infatti manifestate con l’impugnazione ridetta e ciò anche rispetto a quanto quel giudice non ha deciso affatto, nei termini sopra intesi.
Il referente normativo dell’art. 342 c.p.c. lo conferma: la valutazione del primo giudice sull’eccezione è infatti omessa nella motivazione della sua sentenza, onde, rispetto ad essa, la posizione di chi risulti nel merito vittorioso non può che essere omologa a quella dell’appellante principale, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli dà torto, se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell’appello; diversamente, altro contenuto concettuale e normativo assume la mera riproposizione delle difese ed eccezioni.
Con riferimento quindi alle eccezioni di rito, come certamente era quella della tardività della domanda riconvenzionale nel presente caso, in quanto diretta a ottenere la dichiarazione di inammissibilità della medesima, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su dì esse, ma vittoriosa quanto all’esito finale della lite si trovi, dunque, in posizione di soccombenza.
Ne deriva che se essa vuole ottenere che l’eccezione sia riesaminata dal giudice del gravame, investito dell’appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Conclude la Corte ritenendo che l’impugnazione incidentale costituisce l’unico rimedio per ovviare al rigetto (espresso oppure implicito) nonché all’omesso esame (ricomprendendosi in quest’ultima espressione tanto l’ipotesi di illegittima pretermissione quanto la violazione dell’ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte) di una domanda e/o di un’eccezione; la riproposizione entra in gioco nei soli casi in cui non vi è la necessità di spiegare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento, nelle quali la parte può limitarsi – mancando una decisione sulla domanda e/o sull’eccezione avanzata – a proporre nuovamente (per l’appunto, riproporre) l’istanza non esaminata, cioè non accolta in quanto ritualmente assorbita.
Alla luce del sopra richiamato orientamento di legittimità, quindi, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza (teorica), deve spiegare appello incidentale.
Ciò impone, sul piano della tecnica processuale, il rispetto dei rigidi dettami di cui all’art. 342 c.p.c. nonché dei tempi di cui all’art. 343 c.p.c., pena l’inammissibilità del gravame ed il conseguente passaggio in giudicato della stessa questione ex art. 329, comma 2, c.p.c.






Ultimi commenti